Affrontare il tema della violenza di genere a partire dalla letteratura, dai romanzi, nello specifico, significa utilizzare un’ottica straniante sotto la quale guardare al problema e al contempo assumere una “ distanza” letteraria da esso, ma non meno pregnante.
E se scegliamo di farlo non attraverso la solita letteratura didascalica, ovvero quella che propone storie di violenze dal finale tragico o dal finale edificante, ma attraverso percorsi di donne, storie al femminile, allora diventa ancora più obliquo il nostro sguardo, più problematico e ricco di contraddizioni che vanno al di là dell’uomo lupo e della donna agnello. Occorre dunque una breve premessa.
Partiamo dal presupposto che la buona letteratura parla di noi, con noi e per noi. Ci propone storie di cui noi stesse possiamo essere protagoniste, ci incoraggia, ci suggerisce percorsi.
L’altro presupposto è che, per parlare di violenza di genere, occorre parlare di percorsi di autoaffermazione, di lotte secolari, non solo di donne rispetto agli uomini, ma anche di donne rispetto ad altre donne, rispetto agli stereotipi che ci portiamo dentro, che si tramandano di madre in figlia e che scavano nella donna, insieme ai sensi di colpa, una voragine all’interno della quale ella non sa più cosa è bene e cosa è male.
Le storie che racconterò sono dunque storie che suggeriscono spunti di riflessione, prendendo in prestito quelle storie per costruire il mio percorso.
Perchè la letteratura ha senso solo se le storie che raccontiamo riescono a diventare nostre.
Le donne sono da secoli vittime di una diseducazione sentimentale: diseducate ad amare sè stesse, per non scontare poi l’essere chiamate egoiste; diseducate ad affermare sè stesse, per non scontare il disamore dell’uomo, la sua pretesa di essere migliore di lei, di proteggerla e guidarla, anche quando non vi sia alcuna necessità.
Il primo punto di questo percorso parte da lontano, parte da una storia d’amore che sembra raccontata ieri in un tg.
Giorgio Aurispa è un uomo bello e affascinante, un artista. Amante da anni della bellissima Ippolita Sanzio. Una storia d’amore bella e appassionante. Lui , ovviamente brama per averla tutta per sé. Ippolita prende una decisione: lascia il marito e va a vivere con Giorgio. Sembrerebbe un lieto fine, ma è l’inizio della fine. La convivenza di Giorgio con Ippolita lo rende debole, insicuro, lo porta sull’orlo di una nevrosi. Più lei è forte, accogliente, materna, innamorata, più Giorgio sente crescere in lui la debolezza, o meglio teme che essa, latente, si riveli manifesta, ora che non vi sono più scuse e i due stanno assieme. Giorgio diventa esigente, impossibile, spera che Ippolita si stanchi e lo lasci, le attribuisce la sua incapacità, i suoi fallimenti, ma al tempo stesso non ha la forza di lasciarla. Nel suo cuore l’amore inizia a diventare odio e più la sua donna è accondiscendente, più lo comprende e lo aiuta, più in lui cresce una forma di rancore verso di lei. Dalla capitale decide di trasferirsi con lei nel suo piccolo e primitivo paese d’origine, in Abruzzo, sperando che lì, lontano dalla gran vita che erano abituati a fare, in un contesto campestre e umile, lei si stanchi e si decida a lasciarlo. Nelle loro noiose serate spesso lui le chiede cosa farebbe lei senza di lui, la obbliga inoltre a passare in rassegna il suo passato, la sottopone ad un pressing psicologico al quale lei resiste, inspiegabilmente. Nella testa di Giorgio si matura il disegno: deve liberarsene per poter poi liberare se stesso e riprendere a fare la sua vita, ad inseguire i propri sogni che lei gli impedisce di seguire, pensa lui, mentendo a se stesso, pur di non accettare la sua inettitudine. Un giorno i due passeggiano, incontrano per strada un cane nero. Giorgio ha paura dei cani, lo evita. Invece Ippolita gli va incontro e gli tende fiduciosa la mano. E’ l’ennesimo insopportabile smacco alla sua virilità, lei è più forte di lui, è la presa di coscienza insopportabile. In preda ad una follia che ha montato nel corso dei mesi, Giorgio afferra Ippolita e la trascina con sé in un dirupo, uccidendo lei e lui in un omicidio –suicidio. Il primo femminicidio della letteratura moderna reca la firma di Gabriele D’ Annunzio. Anche se sembra una storia di oggi, questo è “Il trionfo della morte”, datato 1894.
Da questo modello disfunzionale di coppia, che è trasversale alla cultura e alla classe sociale, cosi resistente nel tempo, facciamo un salto negli anni 50, attraverso le parole e i ricordi, di una scrittrice francese Annie Ernaux che ha raccontato nei suoi romanzi la sua storia, quella della sua famiglia, l’emancipazione e il riscatto, semplice ma non per questo meno epico, di una ragazza di provincia.
Oggi come allora la strada dell’emancipazione femminile e dell’indipendenza che tengono la donna lontana dalla violenza maschile, è rappresentata dalla scuola, dalla formazione, dall’istruzione e dall’acquisizione di competenze tali da consentire alla donna di crearsi una indipendenza economica.
Nel suo romanzo più famoso “ Gli anni “ la Ernaux scrive:” per le donne della mia generazione più ancora che un modo per affrancarsi dalla miseria, gli studi le paiono lo strumento di lotta privilegiato contro quell’impantanarsi femminile che le suscita pietà, ovvero quella tentazione di perdersi in un uomo “[1].
Con semplicità, senza falsa retorica, la scrittrice francese ci ricorda quanto sia stato difficile diventare donne emancipate, svuotandosi anche della retorica femminista, e lavorare duro per diventare autonome.
Riconosco nelle sue parole l’orgoglio di mia madre, universitaria di provincia negli anni 50, figlia di operai, che ha vissuto la laurea come la chiave per l ‘indipendenza, e ha avuto il coraggio di sposarsi all’epoca dopo i quarant’anni, quando al più si diventava nonne. Che ha rifiutato di fare la maestra, (unico mestiere consentito ad una donna, all’epoca) ,per continuare gli studi e laurearsi .
L’altro grande stereotipo con cui la donna deve confrontarsi è quello ampiamente condiviso dalle sue pari, dalle altre donne, anche quelle più emancipate e trasgressive, in senso borghese, della donna socialmente ben inserita, che dopo i suoi percorsi di
“ ribellione “ ovviamente di maniera e non autentici, dovrà poi rientrare nell’alveo del percorso casa-lavoro-famiglia-figli, vestendo come un tailleur la rispettabilità che le si addice. Ecco che il percorso della consapevolezza che tanta letteratura femminista, (penso anche al famosissimo saggio Donne che corrono coi lupi di Clarissa Pinkola Estes) ha preteso di farci vedere nell’opposizione uomo-donna; cultura archetipa maschilista- cultura dell’emancipazione, si riempie di ombre e di contraddizioni.
Una donna può fronteggiare un uomo e liberarsene anche con fatica, ma durissimo è il destino di una donna che altre donne-amiche convincono di essere “ sbagliata”. Nessuna donna perdona all’altra la sua libertà. E’ un legame più subdolo, un senso di colpa tutto femminile che passa di madre in figlia, di donna in donna, per risvegliare l’archetipo di donna dal quale ci si è allontanati, condannando la ribelle alla solitudine, alla depressione. E’ di questo che parla il coraggiosissimo e velenoso libro di Alicia Gimenez Bartlett che lascia i panni della giallista per raccontare la storia di Sara la “Segreta Penelope” del suo libro. E’ un romanzo sulla mancanza di solidarietà, sulla fine di ogni sbandierata emancipazione e “ sorellitudine”.
La protagonista di Segreta Penelope è la bellissima Sara, ribelle, solare, divertente, una figlia dei fiori che vola di casa in casa, di storie in storie, disordinata e felice. Ma ad un certo punto della sua vita le sue stesse amiche di un tempo, di sempre la convincono che è arrivato il momento di avere una vita felice, integrata e normale. Ma felice per chi ? secondo quali canoni? A trent’anni bisogna mettere da parte le follie concesse in giovinezza e trovare un buon marito, diventare mamma e rientrare nei ranghi. Sara diventa normale, cambia look, va a prendere il caffè con le amiche, fa shopping, ma comincia a sfiorire, ad appassire, a svuotarsi. La bellissima irriverente Sara diventa depressa, va in analisi, su consiglio delle amiche, diventa una donna triste. Alla fine della storia Sara si suicida e lo fa, come sarà costretta ad ammettere la sua migliore amica, divorata dai sensi di colpa, perché ha voluto provare con tutte le sue forze ad essere normale, e ciò l’ha resa patetica, una madre incapace, un essere fragile, desiderosa di dare un padre alla figlia, un disastro assoluto. Una morte assistita, annunciata, proprio dalle sue amiche che l’hanno voluta cambiare. L’universo femminile è uno schifo scrive la Bartlett. Sara era diventata Penelope, una Penelope triste, inadeguata, una maschera di se stessa, costretta a mendicare l’ amore di una figlia che non l’amerà mai.
L’ autrice traccia il ritratto di una generazione di donne, quella alla quale noi stesse apparteniamo“ Essere dei sopravvissuti è una delle ultime consapevolezze della mia generazione… che si realizzino i progetti per i quali abbiamo lottato , non è un gran merito. Sarebbe meraviglioso che si avverassero i nostri sogni senza sporcarsi le mani. Ma sarebbe ancora meglio se non avessimo né sogni , né progetti, se sapessimo vivere nel presente. Godendo fino all’ultimo istante con una intensità animale. Come Sara, bella e fiera nel suo stato originario, non la segreta Penelope in cui l’avevamo trasformata. “[2]
Le donne della giallista spagnola sono dunque più vittime delle donne stesse che non degli uomini, che perdonano l’essere eccentrico, solo se non si mette in crisi l’ordine costituito.
Nella disamina degli stereotipi femminili contro cui ogni donna è chiamata a lottare per liberarsi e per impedire di cadere in ogni forma di sottomissione e di violenza fisica o psicologica, arriviamo ad una favola moderna che ha un gusto dolce amaro.
Questa storia racconta il percorso di una ragazza di oggi, alle prese con la velocità e la capacità di fare tutto bene e in fretta; il modello di donna che deve fare concorrenza a tutti, soprattutto agli uomini; che riempie le giornate di qualcosa; che si mette al fianco di qualcuno, pur di dire io sono, io esisto e sono capace; la sua incapacità di gestire il niente che riempie la mente di idee e di pensieri. Perchè lo stereotipo della donna moderna la vuole a mille, perfetta, magra, istruita, partecipe, tutto, per dimostrare che il mondo non ha sbagliato a darle fiducia. Parliamo della favola per le bambine di oggi che ci racconta Chiara Gamberale, dal titolo Qualcosa.
La protagonista si chiama principessa Qualcosa di troppo, sempre eccessiva, troppo emotiva, troppo divertente, troppo dinamica, in ogni cosa sempre esagerata e si annoiava spesso. Tutta la favola che la autrice ci racconta è il percorso della principessina nel suo graduale affezionarsi alla Madama Noia, a quel vuoto interiore di cui si necessita per capire, per domandarsi, per crescere. In questo percorso l’aiuterà il cavalier Niente che convince la ragazza che la parte più importante di noi è quella piena di niente, perché è lì che una donna sperimenta se stessa e la propria libertà e non lascerà che chiunque la riempia con qualcosa. “ Se non farai pace con lo spazio vuoto dentro di te, nulla davvero potrà riempirti”, una osservazione semplice che invita la giovane donna e diventare niccianamente ciò che si è, liberandosi dall’immagine che gli altri hanno di lei e di ogni proiezione maschile.
“ Sappiamo che dopo qualche anno la principessa incontrò un altro principe, un altro duca, un altro conte. Ma non sposò nessuno di loro “[3]. La principessa visse a lungo, pianse spesso, sorrise spesso, spesso si annoiò e visse non felice e contenta, ma sicuramente come lei voleva vivere.
[1] Ernaux , A: Gli anni, casa editrice L’ orma, Roma 2015, pag 94
[2] Gimenez Bartlett, A._ Segreta Penelope, Sellerio Editore, Palermo 2013, pag 299
[3] Gamberale, C: Qualcosa, Longanesi, Milano, 2017, p.174





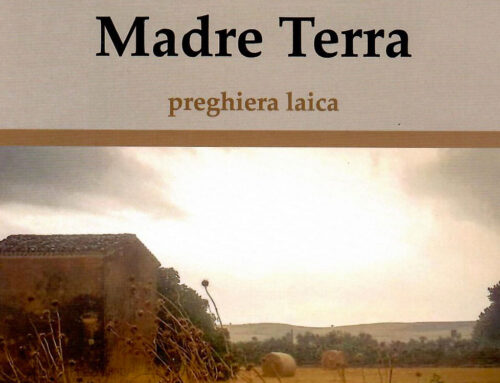


Scrivi un commento