 Davvero la cappella e il quadro di Toro furono realizzati nel 1657, su commissione del notaio Michele De Michele, in rendimento di grazie per essere scampato alla peste che aveva infuriato nell’anno precedente? Per rispondere alla domanda, occorre focalizzare lo sguardo sullo stato di morte e desolazione lasciato dal flagello.
Davvero la cappella e il quadro di Toro furono realizzati nel 1657, su commissione del notaio Michele De Michele, in rendimento di grazie per essere scampato alla peste che aveva infuriato nell’anno precedente? Per rispondere alla domanda, occorre focalizzare lo sguardo sullo stato di morte e desolazione lasciato dal flagello.
Abbiamo già detto dei 240/270 mila morti di Napoli che contava al massimo 450 mila abitanti. Così del mezzo milioni di vittime in totale in un Regno di appena 2 milioni e mezzo di abitanti. E nel Molise? E a Toro in particolare?
In mancanza di altri elementi, le analisi, per macro area o ricondotte a specifiche comunità, vertono di norma sul confronto dei dati della popolazione desunti dalla numerazione dei fuochi, ovvero quella sorta di censimento delle famiglie all’epoca in uso. Sappiamo che nel Seicento il Contado di Molise era molto meno esteso dell’odierno territorio regionale. Tra l’altro non comprendeva il venafrano, né il circondario di Larino, né la fascia adriatica e neppure alcuni comuni come Monacilioni, Ielsi, Gildone e addirittura Ferrazzano a ridosso di Campobasso, che appartenevano alla Capitanata.
Nel 1648 il Molise così circoscritto era abitato da 15129 famiglie. Nel 1660, dopo la peste, tale numero era sceso a 11839, con un decremento assoluto di 3290 famiglie, pari al 21,8 in termini percentuali. Non prendendo in esame eventuali scostamenti dal 1648 a subito prima del contagio, ne discenderebbe che anche nel Contado come nel resto del Regno la peste abbia inciso attorno all’uno su cinque, o poco più.
È assai più complicato passare dal numero delle famiglie estinte al numero dei morti. Di quante unità medie era composta la famiglia? E tale media è rimasta invariata subito dopo la peste? Probabilmente no, per l’ovvio motivo che se furono annientati interi nuclei familiari c’è da supporre anche una pesante decimazione dei componenti delle famiglie superstiti, almeno nell’ordine dell’uno su cinque anche in quest’altro caso. Come calcolare allora il numero complessivo, ben sapendo che i risultati possono variare di molto a seconda del valore assegnato a tali variabili?
Gli studi più recenti tendono a fissare in 5 il numero dei componenti della famiglia media, sia prima che dopo il flagello, e quindi ne deriva che la peste ammazzò 16.450 molisani, pari ai membri di tutte le famiglie estinte, su una popolazione che contava 75.645 in totale. Ma non basta. Bisogna considerare e aggiungere anche le perdite subite dalle famiglie non estinte. Ed ecco allora che è sufficiente, per esempio, fissare in 4 la composizione media familiare all’indomani del flagello, valutando quindi il decesso aggiuntivo di un membro per ogni famiglia non estinta, per vedere salire spaventosamente il numero delle vittime nel Contado di Molise a 28.289, con un incidenza di oltre il 37% sul totale della popolazione, quasi 2 morti ogni 5 abitanti.
Venendo a Toro, il discorso è relativamente più semplice, perché il calcolo per confronto statistico delle numerazioni può essere suffragato dalla documentazione locale. Per tutto il Cinquecento e la prima metà del Seicento il paese si mantiene tra i dieci comuni più popolosi del Contado. La popolazione torese che nella numerazione del 1648 aveva espresso 281 fuochi, nella successiva numerazione del 1669, ne espresse appena 153, uscendone quasi dimezzata. Se moltiplichiamo tali numeri per il fattore 5 (in questo caso mantenuto fermo perché la seconda numerazione ricorre a ben 13 anni dalla peste), otteniamo che su una popolazione di 1405 abitanti, mancano all’appello 640 persone, pari al 45 per cento. Sembrerebbe che la peste abbia ucciso quasi un torese su due, come a Napoli. Numeri agghiaccianti, superiori alle media regionale sopra indicata. Certo è che da allora il paese non ha più riguadagnato le posizioni di preminenza demografica, attestandosi successivamente – anche dopo aver superato lo shock di quegli anni – attorno alla cinquantesima posizione media, a tutt’oggi mantenuta.
Numeri tanto più terribili se si considera che il flagello a Toro esaurì la sua forza distruttiva in poco più di due mesi: dall’ultima settimana di agosto alla fine di ottobre 1656. Lo sappiamo, dal libro dei morti, conservato presso l’archivio parrocchiale che, a far data da fine Cinquecento a inizio Settecento, accoglieva casata per casata il nome dei defunti. E fa impressione vedere che, alle rare annotazioni di norma sparse per i decenni precedenti e quelli successivi, si contrappone un ammasso di nomi e date in corrispondenza di quei due mesi di morte e terrore infernali.
Solo qualche esempio: la casata Francalancia, tra le la più antiche del paese, registrò allora 37 vittime tra i suoi diversi nuclei familiari, 21 vittime i De Martinis – Traboscia, 14 vittime Di Chinco, e via via scemando. Un conteggio pietoso ha portato a fissare in 330 i morti di peste, annotati uno per uno con tanto di nome e cognome, ripartiti per 82 casate.
Come si vede il dato è di molto inferiore a quello sopra calcolato per confronto tra i fuochi, anche perché parziale. Il volume manoscritto, infatti, risulta privo del quinterno di 20 fogli (40 facciate) numerati da 84 a 104, che in base all’indice accoglieva i defunti di altre 11 casate, e alcune di esse, come i Ricella, i Laurelli, i D’Onofrio, popolose e di prestigio. Stando semplicemente alla media del libro, nel quinterno perduto erano registrate almeno altre 45 vittime di cui non conosciamo l’identità. Sale quindi a 93 il numero delle casate toresi distrutte o pesantemente colpite dalla peste e a circa 400 i morti di cui 330 bene identificati.
Dal confronto delle numerazioni del 1648 e del 1669 era scaturito, invece, un decremento di 640 unità. Ne deriva che la perdita delle 240 unità eccedenti non è da imputare direttamente alla peste, ma allo stato di squallore e depressione sociale seguito al contagio nei 13 anni successivi, e protrattosi oltre, ancora per qualche decennio.
Ma su questi numeri magari si tornerà in una sede più specifica, per non gravare ulteriormente di cifre e dati questa nota di carattere meramente divulgativo.
Furono quindi all’incirca 400 i morti provocati dal contagio a Toro, il 28/% di una popolazione che come abbiamo visto toccava appena i 1400 abitanti, e quindi si attestava su posizioni di poco superiori alla popolazione attuale. Per giunta 400 morti registrati in poco più di due mesi, alla media di oltre 6 decessi al giorno. Un’apocalisse che nel giro di qualche settimana, data la saturazione delle fosse comuni ricavate, come allora si usava, sotto il pavimento della chiesa madre, portò alla dispersione dei cadaveri in eccesso per l’agro comunale, dove nei secoli successivi sono stati rinvenuti e ancora si rinvengono i resti di quegli infelici.
Si capisce bene, allora perché davanti alle prime voci allarmate della diffusione dell’epidemia nella capitale e via via nelle provincie e quindi al dramma dei compaesani e dei familiari colpiti e ammazzati dalla peste, un torese sufficientemente agiato, come il notaio Michele De Michele, abbia provveduto a commissionare a titolo di ex-voto la costruzione di una cappella/altare da sistemare nella chiesa francescana di Santa Maria di Loreto. Si capisce la dedica della cappella a un santo come San Nicasio, non particolarmente conosciuto dalle nostre parti ma invocato contro i contagi, a motivo della sua abnegazione di ospedaliere dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Si capisce altresì perché, in obbedienza alla commissione o sua sponte, il pittore Nicola Felice abbia affiancato a San Nicasio, altri quattro santi taumaturghi, medici o intercessori contro la peste.
Peccato, tuttavia, che la gran parte della casata della famiglia del notaio committente, i De Michele, artigiani arrivati a Toro a fine Cinquecento da Jelsi, non ebbe la gioia di rendere grazie e pregare ai piedi del bell’altare e della bellissima tela, né di vederli realizzati. Tra le vittime dell’epidemia, sono elencati i nomi di dieci De Michele, che portano la casata al quarto posto in questa tragica classifica.
Vi compaiono anche alcuni religiosi, come il sacerdote Mercurio, tra i primi morti registrati in paese, e proprio il 26 agosto 1656, nel giorno festivo per eccellenza dedicato al patrono cittadino di cui portava il nome, San Mercurio, o come l’altro sacerdote don Andrea, o come il chierico Antonio, morto non ancora ventenne, il 10 ottobre.
Antonio era il figlio primogenito del nostro committente e della moglie Maria [Antonia] Ricella, a sua volta morta cinque giorni prima, il 5 ottobre. Dopo averli pianti per qualche giorno, il padre e marito, il notaio Michele [Angelo] De Michele, li raggiunse a fine mese, il 30 ottobre 1656. Per ironia del destino fu tra gli ultimi toresi a morire di peste. Aveva poco più di 40 anni. Aveva fatto in tempo a redigere il suo testamento e a commissionare l’altare e il quadro che, realizzati a distanza di qualche mese dalla sua morte, nel 1657, a peste ormai passata, almeno a Toro, testimoniano da allora della tragica sorte sua, della sua famiglia e del suo paese.



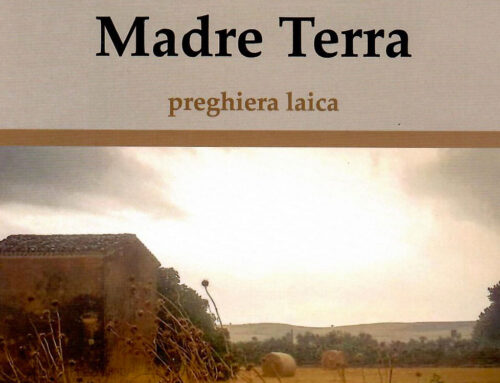




Scrivi un commento