Che presso la Biblioteca Nazionale di Roma sia possibile trovare i libri di Giose Rimanelli non è una notizia. L’obbligo del deposito legale, vigente in Piemonte fin dai tempi di Carlo Alberto, prescriveva che di tutti i libri e di tutte le pubblicazioni che via via si pubblicavano nel Regno fosse depositata copia presso la Biblioteca Nazionale di Torino, sostituita poi – a seguito dell’Unità d’Italia e del trasferimento della capitale – con quella di Firenze, alla quale fu successivamente affiancata la Biblioteca Vittorio Emanuele II di Roma, fondata nel 1875. Quindi non solo dei best-seller rimanelliani, ma di ogni libro pubblicato in Italia da quasi un secolo e mezzo dovrebbe rinvenirsi copia nella biblioteca romana.
Va precisato, a ogni buon conto, che la copia del libro di Rimanelli di cui parliamo, pur se conservata presso la Nazionale di Roma, è catalogata a parte, tra gli oltre 33 mila volumi della biblioteca personale del critico letterario Enrico Falqui, acquisita nel 1976, e aperta al pubblico nella sala riservata, intestata al suo nome.
A essere ancora più precisi, non è di un libro qualsiasi che parliamo. Anzi, non parliamo nemmeno di un libro, ma di una tragedia o, se si vuole, di una commedia. Per giunta in una sola battuta, la quale è stata annotata manoscritta sul frontespizio de Una posizione sociale, il romanzo di Rimanelli pubblicato a Firenze da Vallecchi nel 1959, e poi ristampato con il titolo, La stanza grande, con introduzione di Sebastiano Martelli nel 1996, a Cava dei Tirreni presso Avagliano.
Intendiamoci bene, Rimanelli è stato un autore estroso con tanti meriti, tra i quali non va certamente annoverato quello di aver ideato il teatro dell’assurdo assieme a Beckett, Jonesco e altri. Né tantomeno le tragedie che all’ingrosso potrebbero essere considerate come le antesignane italiane e parodistiche al teatro dell’assurdo: ovvero le Tragedie in due battute, a volte anche in una sola, o addirittura prive di battute, concepite dall’estro di Achille Campanile. Del resto Rimanelli non era ancora nato, o stava emettendo i primi vagiti al cielo di Casacalenda, quando Campanile, nel 1925, presentava le sue microscopiche messinscene, che a dispetto del titolo rientravano nel novero delle commedie e, benché sceneggiate per il teatro, si prestavano meglio a essere lette che rappresentate. Si prenda per esempio una pièce senza battute. Titolo: Un dramma inconsistente; unico personaggio: Nessuno; la scena: “si svolge in nessun luogo”; Nessuno: “(tace)”.
A dispetto della stringatezza delle annotazioni, si capisce che il succo è da ricercarsi proprio nelle note di rappresentazione, che costituiscono l’antefatto della tragedia o, come in questo caso, la tragedia nella sua interezza.
Bene, del dramma rimanelliano abbiamo solo il testo della battuta, scritta e sottoscritta con tanto di firma. Non costa essere mai stato recitato, mentre le note di rappresentazione restano implicite, essendo passati sessanta e più anni. Proviamo perciò ad esplicitarle seguendo lo schema del dramma di Campanile.
Titolo: Una dedica.
Personaggi:
Giose Rimanelli, il dedicatore. (Casacalenda, 1925 – Lowell, Usa, 2018) romanziere e saggista italiano. La sua parabola letteraria, disegnata con successo nel corso degli Anni Cinquanta del secolo scorso con i romanzi Tiro al piccione (Mondadori 1953), Peccato originale (Mondadori 1954), Biglietto di terza (Mondadori 1958) e Una posizione sociale (Vallecchi 1959), fu suggellata e in un certo modo archiviata con Il mestiere del furbo (Sugar 1959), una raccolta di saggi al vetriolo sulla narrativa italiana del tempo, pubblicati con lo pseudonimo, presto smascherato, di A.G. Solari. Quei saggi costarono all’autore – secondo la vulgata rimanelliana – l’ostracismo in patria e la partenza pe’ terre assaje luntane, transoceaniche, dove lo scrittore, non trascurando la carriera accademica nelle università statunitensi, avrebbe continuato a pubblicare, sia in italiano che in inglese, per quanto con esiti meno lusinghieri.
Enrico Falqui, il dedicatario. (Frattamaggiore, 1901 – Roma, 1974) scrittore e critico letterario italiano. Tra l’altro, dal 1948, influente responsabile della terza pagina de «Il Tempo» di Roma. Con buona probabilità, il romanziere Rimanelli ne dové saggiare lo spirito caustico o la castrante indifferenza se a sua volta, in una serie di reportage giornalistici, raccolti poi nel sulfureo volume edito da Sugar nel 1959, indicherà Falqui come l’alfiere di una “forma verminante di quel vario estetismo che, fra le due guerre… di volta in volta si fregiò dei nomi lirico formalistico calligrafico tecnicistico decorativo accademico, eccetera” (p. 16), e anche come il “difensore cieco di quel vittorioso contributo di pensiero e di originalità e di stile offerto dalla prosa d’arte” che “se ne infischia dei narratori” (p. 17), stante l’avversione di Falqui per il romanzo, da lui considerato una forma d’arte ottocentesca, e quindi superata, come i Manzoni, i Verga, i Tozzi, gli Svevo. Insomma per Rimanelli, Falqui è “prigioniero di una casa di vetro, insieme a tutti gli inquilini della prosa d’arte che guardano sì di fuori, ma come certi signorini malati e ostinati, che han paura di respirare l’aria della strada e del mondo, per tema d’infettarsi dei velenosi bacilli della vita” (p. 17). Inoltre, riferendosi a “una certa categoria di critici, nati e invecchiati in una stagione letteraria, patiti della contemporaneità, che oltre non sanno spingersi e tuttavia sono petulanti e insidiosi, mezze maniche eterne che raccolgono… l’acqua con le orecchie”, Rimanelli scriverà che “l’hidalgo di questa categoria è appunto Enrico Falqui, paragrafista, postillatore, indicatore, elzevirista, lessicografo” (pp. 18-19). Falqui che, sempre secondo Rimanelli, “si è accampato su di una generazione del nostro Novecento letterario che ha predicato lo stile e la forma e ne è diventato lo storiografo e il bibliotecario. In più sostiene di incarnare tutto lo spirito risolutivo di questo Novecento, perché avrebbe inventato il capitolo” (p. 19), ovvero il contenitore ideale per la prosa d’arte.
Bene. Nonostante le bordate appena trascritte, estrapolate da un più vasto ragionamento critico, sviluppato da Rimanelli contro Falqui in particolare e i calligrafici in generale, la scena potrebbe svolgersi proprio nel fatidico 1959, l’anno de Una posizione sociale e de Il mestiere del furbo, e proprio nel salotto di casa Falqui, o presso la redazione de «Il Tempo» o anche in una gelateria di Piazza Colonna a Roma o nelle immediate adiacenze, o infine – e sarebbe l’opzione più verosimile – in un qualsiasi ufficio postale. In quest’ultimo caso, com’è ovvio, Falqui sarebbe presente solo in effigie, nei panni dell’addetto all’inoltro dei pacchi e della corrispondenza.
Rimanelli. Nell’atto di stilare la dedica, che firma e legge, prima con gli occhi e quindi ad alta voce, consegnando il libro al dedicatario o alla sua effigie: – A Falqui (anche se mi odia). Rimanelli.
(Sipario).
Per colpa della caduta repentina del sipario, lo spettatore e/o il lettore devono rinunciare al piacere di scoprire se ci fu una reazione da parte di Falqui e in che termini. Se la dovranno immaginare, ben sapendo – tuttavia – che l’omaggio fu ricevuto e conservato e che a distanza dei tantissimi anni trascorsi, la tragicommedia impressa con autografo dell’autore nel frontespizio del libro continua a testimoniare dei due scrittori nel frattempo scomparsi, dei loro odi (magari chi vuole li derubricherà ad antipatie) e di un mondo letterario, che al pari dei protagonisti, non esiste più. O almeno così potrebbe credersi.





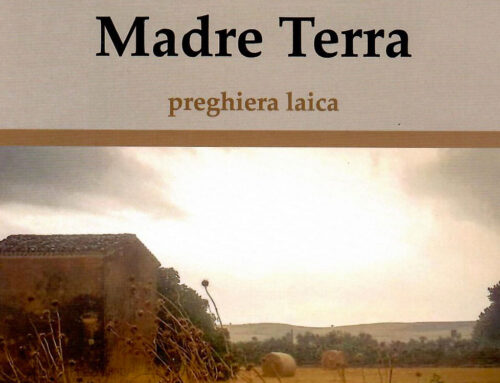


Scrivi un commento