“Uno dopo l’altro, gli sportelli dei vagoni sono chiusi con impeto; forse, pensa un viaggiatore fantastico, dal ferreo destino che , ormai senza rimedio, porterà via lui e i suoi compagni nelle tenebre. La locomotiva fischia, colpi violenti scoppiano di vagone in vagone sino all’ultimo: il convoglio va lentamente sotto l’ampia tettoia, esce dalla luce dei fanali nell’ombra della notte…”
Nel 1881 Antonio Fogazzaro (Vicenza 1842-1911) tramanda un indimenticabile ritratto femminile capace di esercitare uno stranissimo binomio di attrazione e repulsione: parliamo del personaggio di Marina Crusnelli di Malombra nel romanzo Malombra.
Sin dal suo apparire, tale romanzo destò vivo interesse e accese discussioni fra il pubblico e la stessa critica, che non lo accolse favorevolmente, eccezion fatta per Giovanni Verga verista, che lo definì subito un libro notevolissimo (“Una delle più alte e delle più artistiche concezioni romantiche che siano comparse ai nostri giorni in Italia”), uno di quelli – aggiungiamo noi – che, in un certo senso, contraddistinguono un’epoca.
Aveva ragione Verga a celebrare questo romanzo, proprio in ragione del fatto che la giovane Marina, la protagonista del suo romanzo, aveva saputo esprimere i segni premonitori di una crisi epocale.
Sbaglierebbe chi, nel leggere il romanzo, vedesse in lei semplicemente un’improbabile figura di donna sospesa fra tardo Romanticismo, Verismo e prime avvisaglie del Decadentismo, una delle tante eroine di storie esagerate e melodrammatiche, con cui gli scrittori del tempo venivano incontro ai segreti desideri di trasgressione di un pubblico d’ordine, borghese e benpensante.
Nel personaggio di Marina risiede anche questa valenza, che emerge specialmente nella scena finale dell’assassinio dell’amante, Corrado, giovane scrittore sconosciuto in cui si agitano e si scontrano pulsioni idealistiche e religiose e erotico-estetizzanti. Ma c’è anche molto di più: ci sono un’atmosfera torbida e sensuale e una spinta all’autodistruzione, alla degradazione, che sta fra gli echi della Scapigliatura e i presentimenti della grande stagione simbolista, e ci sono – soprattutto – una inquietudine, una tensione cerebrale, una fragilità nervosa e una disperata frustrazione, che sono tutte pulsioni di grande modernità.
Marina ricorda da vicino la Polina de Il giocatore di Fedor Dostojewski e anche la Katerina Ivanovna de I fratelli Karamazov: altera, superba, intelligente, una bellezza alquanto algida e scostante e, al tempo stesso, tormentata da demoni e fantasmi; dilaniata da passioni impetuose che, per orgoglio, cerca di soffocare o, almeno, di dissimulare; irresistibilmente attratta dalla sofferenza, la tortura autoinflitta, la disgregazione del proprio io e l’umiliazione del proprio orgoglio.
Su di lei incombe, fin dall’inizio, un’atmosfera da antica tragedia greca: un’aura maligna la circonda, l’avvolge, l’accompagna passo dopo passo, giorno dopo giorno, verso l’ineluttabile caduta; su di lei pesano le nuvole opprimenti della claustrofobia spirituale, dell’isolamento morboso, del masochistico piacere d’infliggersi la peggior forma di infelicità.
Moderna, assolutamente moderna, è dunque Marina: nella sua cultura che non le apre gli orizzonti dello spirito; nella sua raffinatezza che non è lo specchio di un equilibrio raggiunto e conquistato; nella sua alterigia che non nasce dalla consapevolezza della propria forza, ma dal terrore della propria debolezza; negli atteggiamenti di sfida che sono, in fondo, altrettante invocazioni, mal dissimulate, d’aiuto e di soccorso; nel suo rinchiudersi, inesorabile, come conseguenza della percezione della propria fondamentale inadeguatezza.
Marina è atterrita dalla vita: il suo spavento non nasce da una consapevole infrazione del codice sociale dominante, da una ribellione intenzionale alle leggi non scritte, ma inflessibili, della rispettabilità borghese, ma le sue paure sono generate dalla vita, così come si va configurando nella esordiente società di massa. Aristocratica per temperamento prima ancora che per nascita o per scelta, rappresenta l’impossibilità di adeguarsi ai nuovi stili e ritmi della borghesia imprenditoriale; c’è in lei qualcosa di antico, di obsoleto, di irrimediabilmente superato, come le “care, vecchie cose di pessimo gusto” di Guido Gozzano, ma senza l’ironia salvifica che percorre le pagine dello scrittore decadentista torinese.
E si capisce. Fogazzaro appartiene al Veneto profondo, al Veneto che rimase austriaco fino al 1866, al Veneto cattolico che ha dato tanti santi e tanti uomini di chiesa, ultimo papa Pio X che si scaglierà con violenza contro il modernismo, provocando nello scrittore vicentino una drammatica crisi di coscienza, che sarebbe culminata nella sottomissione al magistero ecclesiastico, lasciando però nel suo animo ferite profonde, mai del tutto risanate.
In Marina, dunque, coesistono il desiderio della trasgressione e il dilaniante senso della colpa; la fedeltà alla morale ricevuta dall’educazione e la spinta verso il proibito, il sensuale, il peccaminoso.
E tutto ciò è straordinariamente moderno, più moderno, forse, della furia carnale della Lupa di Verga, o della follia sadica e omosessuale della Ninì di Vasco Pratolini, oppure della virile e inesauribile forza d’animo dell’Andreana di Marino Moretti.
Per trovare un personaggio femminile che possa esserle paragonato, per disperata vocazione alla solitudine radicale e per incolmabile divario fra sogni bovaristici e coscienza della propria impotenza, bisognerà arrivare alla scultorea, indimenticabile Adriana Mesurat di Julien Green e, in misura minore, alla stanchezza e al progressivo inaridimento della Gisella di Carlo Cassola.
Non è tanto importante la parentela nella malattia mentale, che conduce sia Marina sia Adriana Mesurat a commettere un delitto senza redenzione, quanto la parentela psicologica e spirituale nella solitudine, nell’orgoglio senza sbocchi, nel vano fantasticare che dissimula una fondamentale incapacità – o impossibilità – di accettazione della vita.
Ecco allora che anche la malattia mentale da cui è afflitta Marina – ossia la convinzione di essere la reincarnazione di una sua antenata, Cecilia, che per un peccato d’amore era stata segregata a vita dal marito e ora Marina vuol vendicare nelle persone dello zio, conte Cesare d’Ormengo (da lei creduto il marito di Cecilia) e poi anche di Corrado Silla (creduto, sempre da lei, la reincarnazione dell’antico amante) – diventa un elemento non già convenzionale e secondario, ma in un certo senso la metafora di un male molto più profondo e sconosciuto, che affonda le radici nella nuova condizione della donna all’interno della società borghese, industriale, di massa.
Da questo punto di vista, il fatto che Marina provochi la morte sia dello zio Cesare sia dell’amante Corrado, non va visto alla luce del classico archetipo baudelairiano della donna-vampiro, distruttrice degli uomini che incontra nella vita, quanto alla luce di una furia distruttiva che, oltre ad essere eterodiretta, finisce inevitabilmente per ritornare a lei come un boomerang e, dunque, come una preparazione e una sorta di prova generale dell’ultimo e definitivo delitto: quello contro se stessa.
La sua unica salvezza sarebbe quella di riversare le proprie paure e le proprie angosce nelle braccia di un uomo virile, che la sappia proteggere, rassicurare, pacificare con la parte sofferente e più profonda del suo io; che l’aiuti ad affrontare, uno a uno, i fantasmi che si agitano in lei, implacabili come le Furie della mitologia antica. Ma ciò non avviene e la ragione va ricercata, molto probabilmente, nella stessa “astuzia” del suo istinto femminile: istinto di malata che non vuol guarire, di naufraga che non vuol essere salvata, ma che vuole, al contrario, perdersi.
E Marina si perde non per inadeguatezza di un uomo. Marina si perde perché in fondo al suo essere desidera perdersi (e poco importa come: nelle ultime pagine del romanzo la vediamo allontanarsi, a forza di remi, sull’orizzonte cupo del lago del Segrino, in Brianza. Forse finirà annegata, forse si getterà in una forra della riva opposta, tra boschi e rocce). Desidera perdersi Marina perché nell’autodistruzione intuisce la sola via di fuga che le rimane aperta dinanzi e forse la sola possibile catarsi, la sola possibile redenzione, dopo che né Dio né gli uomini hanno potuto o voluto salvarla.
Il fantasma che la possiede – l’ossessione di essere la reincarnazione dell’antenata Cecilia e di avere come scopo la vendetta contro lo zio, il conte Cesare d’Ormengo – non è che la condensazione di un altro fantasma, consustanziale alla sua anima: la consapevolezza della propria inettitudine e la lotta incessante fra il desiderio di felicità e la volontà di autopunizione: non per una specifica azione, ma per il fatto stesso di esistere.
Una breve scena notturna nell’antico palazzo ove Marina vive sepolta (la Villa Pliniana sul Lago di Como, ove Mario Soldati girerà, nel 1942, una bellissima versione cinematografica del romanzo), bene illustra l’angoscia esistenziale della giovane e l’errore da lei commesso nell’affidarsi a un amante ancor più di lei, se possibile, insicuro e bisognoso di conforto e protezione.
Dall’opera (Mondadori, Milano 1931; 1965, pp. 301-302):
Marina discese lentamente, con piedi silenziosi di fata, in mezzo alla larga scala semioscura. Silla le teneva dietro, stretto alla gola da emozioni inesprimibili, quasi cieco. Ancora un momento e sarebbe stato solo con lei, nella notte.
La porta a vetri che mette in giardino era spalancata. Il lume del vestibolo, oscillando all’aria notturna, mostrava di fuori un lembo di ghiaia rosea; presso all’uscio, presso una sedia, lo scialle bianco di Marina. Ella lo porse a Silla, si fermò perché glielo posasse sulle spalle. Le loro mani si incontrarono; eran gelate.
«Fa freddo», disse Marina, stringendosi lo scialle sul petto. Pareva un’altra voce; quasi tremante. Silla non rispose; credeva ch’ella gli sentisse il cuore a battere. Le posò un momento le mani alle braccia quasi per ravviarle lo scialle. Ella trasalì; le spalle, il seno le si sollevarono. Uscì senza dire parola, fece una cinquantina di passi nel viale e s’appoggiò alla balaustrata, guardando il lago.
La notte era oscura. Poche stelle lucevano nel cielo nebbioso fra le enormi montagne nere che affondavano l’ombre nel lago. Il gorgoglio delle fontane, il canto lontano dei grilli nelle praterie, andavano e venivano col vento.
“Silla non vedeva che la elegante figura bianca, curva sulla balaustrata presso a lui.
«Cecilia» disse piano accostandosele.
Ell’appoggiava il mento alle mani congiunte. Ne stese una a Silla senza voltar la testa, e gli disse appassionatamente:
«Sì, mi chiami sempre così. Si ricorda?»
Egli strinse con ambedue le proprie quella mano di raso odoroso. Temeva di esser freddo, di non aver neppur sensi in quel momento. Se la recò alle labbra, ve le impresse, veementi, sul polso.
«Mi dica: si ricorda?» ripeté Marina.
«Oh, Cecilia!» diss’egli. Le voltò la mano, vi abbassò rapidamente il viso sul palmo, se la serrò sugli occhi, parlò convulso:
«Non v’è più mondo, se sapesse, per me! Non vi son parenti, né amici, né passato, né avvenire; niente, niente; non v’è che Lei; mi prenda, mi prenda tutto!»
Voleva esaltarsi e vi riusciva. Si trasse quel piccolo palmo sulla bocca; pensò alla propria vita amara, al mondo ingiusto, vi soffocò uno spasimo di passione che dovette entrar nel sangue di lei, attraversandolo sino al cuore.
«No, no», diceva ella con voce interrotta, mancante, «adesso no».
Avevan la febbre tutti e due.
Povera Marina! Cercava sicurezza e protezione da un uomo che ne aveva bisogno egli per primo e che si offriva a lei come, di solito, una ragazza si offre a un amante (“Mi prenda, mi prenda tutto!”). Eppure è giovane, bella, alta, intelligente, colta e infine ricca: potrebbe far innamorare qualsiasi uomo. Perché dunque sceglie così male la persona con cui confidarsi, con cui aprirsi, alla quale appoggiarsi?
Fondamentalmente la risposta è che Marina, nonostante le apparenze sembrino indicare il contrario, non ha di sé alcuna stima. Ma è troppo orgogliosa per ammetterlo, anche a se stessa, perciò si condanna a ripetere i medesimi errori, a ricadere nelle stesse situazioni false da cui ricaverà solo sofferenza e ulteriore solitudine.
Malombra non fu la prima prova letteraria di Fogazzaro, in quanto romanzo preceduto dal poemetto in versi Miranda (1874) e dalla raccolta di poesie Valsolda del 1876, ma risultò sicuramente l’opera che contribuì a farlo conoscere e amare dal grande pubblico, forse ancor più del suo riconosciuto capolavoro, il romanzo Piccolo Mondo Antico (1895), ambientato in Valsolda, sul lago di Lugano, e popolato di figure familiari che conducono una vita in apparenza uguale, ma in realtà assai ricca di profonda poesia. Seguiranno altri tre romanzi a comporre una tetralogia legata al tenue filo della discendenza dei personaggi: Piccolo mondo moderno (1901), Il santo (1905) e Leila (1910).
In Malombra, a ben guardare, sono visibili molti segnali che anticipano la dicotomia propria del Novecento letterario. I temi prediletti dall’autore in tutta la sua produzione, cioè quelli del mistero, del misticismo, della follia, dell’opera consolatrice della religione, della ragione contro la dottrina, del mondo reale contrapposto alla sfera spirituale e sovrannaturale, si evidenziano particolarmente in questo romanzo, annunciando di fatto la poetica che sarà poi caratteristica del filone della Scapigliatura e del Decadentismo.
Malombra esce in contemporanea con i Malavoglia di Giovanni Verga e rappresenta per il Verismo la raffigurazione, per così dire, “aristocratica” della realtà contemporanea, contribuendo a fornire uno dei maggiori affreschi sociali e culturali del tempo mai tracciati sino a quel momento.
Aderente dunque ai canoni della Scapigliatura Milanese, ma anche della letteratura verista e soprattutto del romanzo gotico per le tetre ambientazioni, Malombra è romanzo di poetica pure tardo-romantica, in quanto protagonista è l’animo umano in tutte le sue complessità e contraddizioni.
Tipici del Romanticismo sono infatti gli incessanti contrasti e confronti tra passionalità dei sensi e sentimento religioso, tra pulsioni emotive e rigida morale, tra desideri ardenti e costumanza sociale; le lacerazioni dell’animo che, impotente dinanzi allo svolgersi degli eventi, non riesce in alcun modo a conciliare i diversi aspetti della vita, quello materiale e quello spirituale; l’incapacità di aderire agli schemi precostituiti di perbenismo all’interno di una struttura sociale che va facendosi sempre più restrittiva; l’aspirazione artistica a elevarsi al di sopra e oltre le abituali consuetudini; l’illusione di essere sempre migliori e diversi da quello che si è; il tentativo pervicace ed estremo di valicare gli ultimi confini, andando sempre più avanti. Tutto questo fa di Malombra una pietra miliare del canone Romantico, grazie all’esasperazione della soggettività della protagonista, avvicinandosi a gran passi al Decadentismo.
Solo un’opera veramente matura come questa può recare al loro interno i germi e le ramificazioni di correnti letterarie tanto diverse tra loro, fondendosi comunque perfettamente e conferendo al romanzo tutte le connotazioni del moderno thriller psicologico.
La trama è di quelle indimenticabili.
Sapida di tutti gli ingredienti classici della narrazione, inserita in un contesto sociale adeguato e ritrattistico come vero affresco sociale, innestata in un’ambientazione naturalistica selvaggia e brutale che drammatizza gli eventi, contiene la giusta dose di misticismo e spiritismo, sottolineando la raffinata atmosfera sensuale, al limite di un sofisticato erotismo mentale, la reazione esasperata al Positivismo dilagante dell’epoca e i sapienti accenni al paranormale, palesati oltre la falsa maschera della maledizione di famiglia e della possessione isterica.
Ambientata in Lombardia, in un lugubre castello posto sulle rive del lago di Como, luogo incantatore e maliardo per eccellenza tanto caro anche al Manzoni, la vicenda narra di Marina di Malombra, di nobili natali, costretta a vivere in una sorta di malinconico esilio dallo zio Cesare d’Ormengo, che conta di trattenerla con sé fino alle nozze, ancora tutte da decidere.
Di temperamento ribelle, portata alla malinconia, votata agli eccessi, Marina vive come reclusione forzata questo suo isolamento e vaga per le stanze del maniero in preda a vere e proprie crisi mistiche o depressive.
In uno di questi momenti rinviene casualmente, nel cassetto segreto di un antico scrittoio, delle reliquie appartenute alla sua ava, donna Cecilia, madre di Cesare d’Ormengo e dunque nonna, anche se indiretta, di Marina.
Si tratta di una ciocca di capelli, di un medaglione e di un memoriale, nel quale la sventurata donna narra della sua triste storia. Colpevole di adulterio nei confronti di un giovane e maliardo ufficiale di nome Renato, è stata costretta a vivere segregata, o forse sepolta viva, nelle stanze più isolate del castello, fino a morirne.
Leggendo le memorie, sfiorando il medaglione, avvicinando la ciocca di capelli ai suoi, Marina crede di rivivere la stessa sorte, di essere quindi in qualche modo muta protagonista di un passaggio ideale di testimone tra lei e la sua antica e sfortunata ava.
Ossessionata da questo pensiero, Marina si convince di essere la reincarnazione vivente di donna Cecilia e di essere predestinata a subire lo stesso fato.
Quasi invasata e in preda a progressivi stati di allucinazione, la Marchesa di Malombra perde definitivamente i contatti con la realtà, allorché conosce Corrado Silla, giovane studioso di cui si era già invaghita nel corso di un carteggio segreto e di cui solo in un secondo tempo riconosce l’identità.
Una volta appurato che è proprio il focoso amante intellettuale di cui si era infatuata per iscritto, dopo il primo entusiasmo iniziale, i loro rapporti si raffreddano, quando Marina, ingiustamente, sospetta sia il figlio illegittimo dello zio Cesare, e dunque interessato a chiederla in matrimonio solo per rientrare in possesso del patrimonio di famiglia.
Tra equivoci e risentimenti la situazione si fa sempre più tesa fino a che Corrado, sconvolto dagli atteggiamenti deliranti di Marina, abbandona Como per Milano, dove crede di trovare conforto nell’affetto di una fanciulla più cauta, remissiva e religiosa, anche lei in certa misura legata agli interessi del Castello di Malombra.
Sconvolta dall’abbandono, Marina Crusnelli di Malombra perde definitivamente la ragione e attenta alla vita dello zio, apparendogli improvvisamente la notte in camera e fingendosi lo spettro vendicatore di donna Cecilia.
Colto da malore, Cesare d’Ormengo versa in fin di vita e un telegramma, firmato Cecilia, richiama urgentemente Corrado al maniero.
Sarà però il preludio non di una benefica riconciliazione, ma il pretesto per aggravare ulteriormente la tensione, fino al drammatico epilogo. Marina uccide con un colpo di pistola a tradimento Corrado e poi fugge nelle acque tempestose del lago a bordo di una piccola imbarcazione a remi.
Da questo viaggio simbolico, sballottata tra i flutti delle sue passioni mai domate, travolta dalle onde del suo spirito confuso e tormentato, in preda alla bufera della sua possessione satanica inutilmente mascherata da follia e infine annegata nella sua incapacità totale di adeguarsi alla vita, Marina di Malombra non farà mai più ritorno, lasciando il lettore perplesso sulla riva, intento a meditare sulle eterne problematiche della psiche umana.
Sintesi estrema del malessere crescente dell’età Romantica, il romanzo rimane il capostipite di un filone letterario che non conosce tramonti, in quanto analizza qualcosa che mai interamente potrà essere spiegato, a dispetto di tutti gli studi scientifici, parapsicologici, psichici, metafisici e religiosi che si potrebbero compiere.



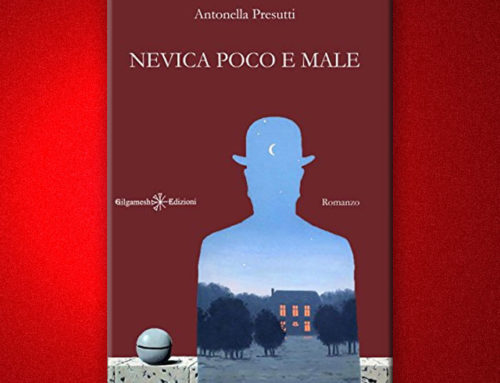




Scrivi un commento