Ciao Valentino
Ti scrivo da Vitorchiano, è il 10 aprile 2020, sono giorni che ci crollano intorno di continuo, giorni dove il tempo è diventato un oggetto, dove il tempo ha perduto la sua forza, il suo essere invisibile, per diventare qualcosa di concreto, qualcosa che ci scorre addosso come un cumulo di macerie.
Mi trovo in campagna, qui, intorno a me, ci sono campi sconfinati e ulivi secolari, c’è un albero di amarene che è fiorito da poco e quei rami sembrano ricoperti da piccole scaglie di neve, ci sono i gatti che si crogiolano al sole; qui ci sono volpi che raggiungono la casa in cerca di cibo o, forse, solamente per capire come mai gli uomini non la smettono di restare in casa, come mai gli uomini passeggiano con indolenza sull’erba, nei boschi, osservano silenziosi il vento che frusta i rami come se fuori alle porte ci fosse un nemico invincibile, un mostro che bisogna lasciare distante dalla fortezza.
I miei giorni sono cambiati, ma non in maniera netta, la mattina scrivo, poi faccio lunghe passeggiate nella boscaglia, il pomeriggio leggo, ascolto musica, torno a passeggiare.
È cambiata la maniera in cui le giornate mi restano attaccate addosso, è come se le ore fossero diventate liquide, si incollano alla pelle, ai pensieri, e fanno fatica a colare via.
In questo mese, oramai passato, ho sentito forte la mancanza di mio padre, ho sentito violenta la vicinanza della morte, perché quando ti manca un defunto sei vicino ai luoghi che dentro la memoria continuano ad accadere, sei vicino alle foto sbiadite, consumate, a quelle foto lasciate dentro un cassetto o a prendere polvere all’interno di cornici argentate, cornici dalle quali si può sentire la voce di chi non c’è più. Gli ho parlato con le preghiere laiche, con i movimenti del corpo, con le parole scritte e cancellate a ancora scritte sopra fogli elettronici o di carta.
Fuori, intanto, è come se la realtà continuasse ad accartocciarsi su se stessa, si prende l’automobile come se fosse un gesto che dona spavento, per fare una spesa fugace, con il volto coperto dalla mascherina e i guanti di lattice a raccontarti la distanza che c’è tra la tua pelle e il mondo fuori, una distanza minima ma che ti isola.
La strada che porta a questa casa, immersa nella campagna della Tuscia, è un sentiero sterrato; questa è una terra feconda, piena di linfa dove la sospensione dei minuti somiglia ad una favola, una di quelle da raccontare davanti alle fiamme di un camino e dove ho imparato, grazie alla noia, ad ascoltare le cornacchie che si affollano sull’erba, l’asino che raglia poco distante da qui, le api che ronzano e si accalcano su fiori che posseggono tutti i colori dell’universo.
Mi sto lasciando crescere la barba e i capelli cresceranno per mancanza di alternative; siamo tutti dentro un carnevale, siamo saliti di malavoglia sopra una giostra che si muove come se ogni cosa intorno a noi fosse un perpetuo terremoto.
E ancora ti parlo dei defunti, dei morti, che somigliano ad un laccio che ci tiene legati alle ore più buie che non abbiamo conosciuto ma che ci sono state raccontate; quando mio nonno tornava dalla campagna con la busta piena di mandaranci, quando mia nonna preparava il forno a legna per la Pasqua, per cuocere le pastiere di riso, quella salata fatta con cicoli, sugna, riso, pecorino, pepe e grano.
I sogni di queste notti sono sogni affollati, dove ai visi che mi circondano si mischiano i corpi di chi ha lasciato la vita per scelta o per costrizione, e questi sogni somigliano a delle suppliche sussurrate a denti stretti e spesso la mattina ho la mascella indolenzita.
Faccio gesti che ho visto fare quando ero un bambino, quei movimenti che sono una spiegazione della vita, bevo vino o birra, ho dei buchi grandi dentro lo stomaco che mi raccontano della fame, della fame che comunica con il corpo nello stesso modo in cui comunica la paura, le gambe molli, a volte, i vuoti improvvisi appena sotto il torace, le braccia slegate.
Resto aggrappato ai movimenti delle piante, alle folate di vento, al profumo di lavanda che si spande nell’aria e che ti fa credere in qualcosa di migliore; resto legato ai tramonti che qui sono di una bellezza dolorosa, quando dalla finestra della sala da pranzo vedo il sole rosso, a volte rosato, perdere forza dietro le montagne e poi c’è Montefiascone che si staglia sopra una collina e un cielo striato di viola e blu e rosa e giallo.
Mi aiutano i libri, mi aiutano le cose scritte, mie o degli altri, mi aiuta mia moglie.
Cerco salvezza nella letteratura, nelle frasi selvagge, quelle che ci riempiono lo sguardo di stupore.
Adesso, mentre ti scrivo, fuori c’è una primavera che esplode ovunque, incurante del contagio, incurante dei morti, incurante della battaglia e forse è giusto così.
Ti abbraccio
Francesco
*********
Francesco Borrasso (Caserta,1983).
È scrittore ed editor. Si è diplomato in regia cinematografica alla scuola di cinema napoletana: Pigrecoemme. Ha esordito con il romanzo La bambina celeste (Ad est dell’equatore, 2016). Ha poi pubblicato la raccolta di racconti Storia dei miei fantasmi (Caffèorchidea, 2017). Ha curato la raccolta di racconti di autori vari Polittico (Caffèorchidea, 2019).
Tiene corsi di scrittura creativa. Collabora con Sul Romanzo, curando la rubrica La bellezza nascosta. Collabora con Nazione Indiana. Editor per la casa editrice Caffèorchidea.





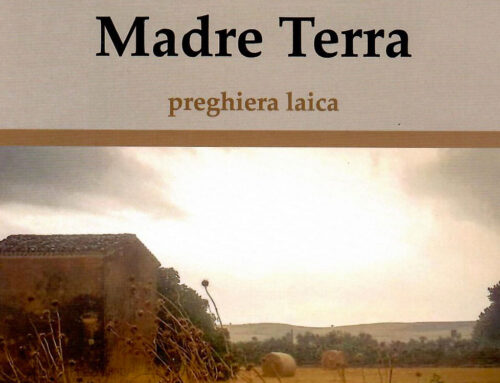


Scrivi un commento