Vastissimo e proteiforme – e sicuramente terreno ancora ricco di tesori nascosti –, il corpus delle prose di Giacomo Leopardi si presta con difficoltà a ogni tentativo di descrizione unitaria.
Infatti lo scrittore vi indossa innumerevoli maschere con naturalezza e facendole cadere con altrettanta noncuranza, in una sovrana padronanza espressiva, lasciando il lettore smarrito dinanzi all’energia centrifuga di tale suo insaziabile sperimentare.
Molto più che l’opera in versi, ricomposta perlomeno a posteriori dalla mirabile organizzazione architettonica dei Canti, sono di fatto le prose a rivelarci come ognuna delle componenti della cultura e della sensibilità leopardiane sia stata coltivata sino alle sue estreme conseguenze, ovvero al limite massimo di una sua perfezione.
Come in quella di W. Goethe, ma diversamente da lui, nell’esperienza creativa di Leopardi sembrano darsi convegno le aspirazioni e le possibilità di un’intera letteratura.
In lui l’erudito e il filologo stanno accanto al prosatore filosofico, l’acutissimo teorico della letteratura si misura con il moralista, il compositore di abili pastiches si abbassa all’affettuoso epistolografo, senza che mai la mistificazione di una sintesi giunga a rendere completa ragione di tante ricerche, di tanti progetti e di altrettanti tentativi.
È semmai nell’acutissima, mai distratta, consapevolezza espressiva, nella massima cura dell’esecuzione, insomma nel sentimento coerente di una cifra stilistica, della cui luce radente ogni pagina conserva un particolare riflesso, che l’aristocratico Leopardi poté riconoscere il fondamento della sua ispirazione, della propria irripetibile originalità di scrittore.
“Togliete i pregi dello stesso – annota nello Zibaldone dei pensieri il 19 giugno 1823 – anche ad un’opera che voi credete di stimare principalmente per i pensieri, e vedete quanta stima voi ne potete più fare”; e sulla energia dello stile “dalle cui virtù principalmente, e dalla cui perfezione, dipende la perpetuità delle opere che cadono in qualunque modo nel genere delle lettere amene”.
“Si può essere poeta – aveva già annotato nello stesso Zibaldone nel novembre del 1821 – non avendo altro di poetico che lo stile.”
Racchiusa proprio nel significato di queste parole si può ravvisare la filigrana della posizione, storica ed estetica, e prima di tutto psicologica, di Leopardi, generando così quel mito critico dello “stile leopardiano”, come sembra rivelarsi soprattutto nelle prose (Zibaldone dei pensieri, Operette morali, Pensieri) che si sono poi rivelate esperienze capitali lungo tutto il Novecento.
Mi piace menzionare a riguardo Italo Svevo, che nell’apocalittico finale della Coscienza di Zeno, nel mondo ritornato alla “forma di nebulosa” che vaga nei cieli finalmente liberi “di parassiti e di malattie”, poté accogliere nella sua narrazione la risonanza profonda delle battute conclusive del Cantico del gallo silvestre; o Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il cui finale contempla il “mucchietto di polvere livida” in cui tutto è destinato a risolversi.
Penso a Italo Calvino, prima di tutto, che proprio sul nitore immaginativo e concettuale delle Operette morali modellò più di un aspetto del suo linguaggio narrativo, scarno di agitazioni superficiali ma sempre disposto a vertiginose avventure del pensiero.
Cristina Campo, poeta, non esiterà a definire Leopardi “l’ultimo critico”… “primo ad esaminare una pagina come si deve, al modo cioè di un paleografo, su cinque o sei piani insieme: dal sentimento dei destini all’opportunità del concorso delle vocali. La esaminò, vale a dire, da scrittore.”
E Anna Maria Ortese, che sulle pendici del Vesuvio cantate nella Ginestra, ha ambientato Il Cardillo addolorato, ricordandosi in più d’un passo del suo lungo e complesso romanzo spunti immaginativi e meditativi offerti non solo dai Canti, ma soprattutto dalle invenzioni fantastiche delle Operette morali.
Leopardi – e ciò si accoglie dal Discorso di un Italiano intorno alla poesia romantica – si dimostra infatti capace di variazioni di inaudita profondità, che gli sono sempre suggerite dalla constatazione di un pericoloso “stato di emergenza” in cui versano le capacità percettive e fantastiche della modernità. Compito del poeta non sarà dunque quello di imitare semplicemente la natura, alla maniera romantica, ma anche di “manifestarla”, ripristinando una relazione autentica con quella duplice infanzia, che fu condizione dell’intera umanità nei tempi precedenti alla corruzione e che è attualmente (dice Leopardi) esperibile nei primi anni di vita di ogni singolo individuo. È in questa sterminata operazione della fantasia che può radicarsi una meditazione sullo stile.
Il nome che indica tale felice pienezza di relazione fra lingua e mondo, fra soggetto e ambiente, fra sensi e apparenza, è naturalezza: la celeste, la immortale naturalezza simboleggiata nel Discorso nel richiamo a Mosco e a Virgilio.
E imitazione. Su questo concetto scrive nello Zibaldone (1821): “Io nel povero ingegno mio, non ho riconosciuto altra differenza dagl’ingegni volgari che una facilità di assuefarlo a quello che io volessi, e di fargli contrarre abitudine forte e radicata, in poco tempo. Leggendo una poesia, divenir facile poeta: un logico, logico; un pensatore, acquistar subito l’abito di pensare nella giornata; uno stile, saperlo subito o ben presto imitare ec.; una maniera di tratto che mi paresse conveniente contrarne l’abitudine in poco d’ora ec.”.
Come spesso accade nello Zibaldone, il pensiero assume una curvatura risolutamente autobiografica e qui è proprio il concetto di imitazione, su cui la tradizione italiana si interroga già dai tempi di Francesco Petrarca, a rientrare all’interno di un ritratto psicologico.
Altro aspetto del Leopardi prosatore si accoglie dal suo rapporto epistolare con Pietro Giordani. Nella lettera datata 30 aprile 1817 si dibatte infatti di questioni linguistiche e Giordani si professa “purista”, di un “purismo” tuttavia diverso da quello di un Cesari o di un Perticari o di un Botta.
Al Giordani, più che un’astratta purezza del lessico italiano, interessa infatti lo stile, ed è esattamente dalle sue proprietà che fa discendere la coerenza dei propri giudizi critici.
Migliore insegnante al giovane malinconico rinchiuso nella “caverna” recanatese non poteva toccare, ma Leopardi non è tuttavia per nulla disposto ad accettare supinamente gli straordinari consigli del suo precettore. Infatti nel Diario del primo amore, che scriverà di lì a poco, della prosa dirà: “L’affettazione e lo stento si vedono come un bufalo nella neve, e nella poesia non così facilmente, primo, perché moltissime cose sono affettazioni e stiracchiature nella prosa, e nella poesia no, e pochissime che nella prosa nol sono, lo sono in poesia, secondo, perché anche quelle che in poesia sono veramente affettazioni, dalla armonia e dal linguaggio poetico son celate facilmente, tanto che appena si travedono.”
Prima meditazione, questa, sul fattore di rischio insito nella prosa che deriva dalla sua stessa nudità retorica, dalla impossibilità di nascondere, mediante l’”armonia” degli istituti poetici, quei probabili difetti che invece balzeranno agli occhi “come un bufalo nella neve”.
Fatto sta che gli anni dal triennio 1817-1819 al 1824 (dalla stesura del Diario del primo amore, del Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, delle prime pagine dello Zibaldone dei pensieri, ai mesi della straordinaria fioritura consecutiva del primo nucleo delle Operette Morali) sono interessati da una costante meditazione sullo stile della prosa.
E questa meditazione non può che trovare in quella parallela sul comporre poesia le sue coordinate fondamentali.
In merito, illuminante è la p. 29 dello Zibaldone, in cui è la teorèsi letteraria leopardiana sulla necessità di un nutrimento reciproco tra poesia e prosa. Perché quest’ultima sia veramente “bella”, si legge poche pagine dopo, è necessario che “abbia sempre qualche cosa del poetico”: non questo o quell’artificio particolare, si badi, ma “una mezza tinta generale”, quel non so che d’indefinito evocato ancora come condizione della “vera nobiltà” dello stile prosaico.
Non si deve ad ogni modo considerare il Leopardi che si avvia alla stesura delle Operette morali e dei Pensieri, antesignano dell’ideale simbolista di un regime di totale indistinzione fra i domini stilistici e retorici della prosa e della poesia (di quella prosa poetica di cui parla cioè C. Baudelaire).
Nulla di più estraneo a Leopardi, che aveva invece un sentimento della differenza, si direbbe, esistenziale prima ancora che stilistica fra l’esperienza della prosa e quella della poesia, tanto da farne addirittura un punto di passaggio decisivo nel “mito biografico” disegnato nei Canti, celebrando con Il Risorgimento, nell’aprile del 1828, la fine di un lungo periodo di silenzio.
La prosa, dirà ancora nello Zibaldone, “non è uno scrivere ispirato”; con V. Monti dirà che “la prosa è la parte più naturale, usuale, e quindi principale di una lingua, e la perfezione di una lingua consiste essenzialmente nella prosa.”
Come P. Giordani, e soprattutto come A. Manzoni, Leopardi sembra giungere a identificare pienamente, negli anni Venti dell’Ottocento, questione della lingua e questione della prosa, accompagnando – come per Manzoni – la riflessione teorica a un costante esercizio quotidiano – quello dello Zibaldone e delle lettere, dai volgarizzamenti ai saggi critici –, tutti banchi di prova di quel fondamentale compromesso tra “facoltà d’imitare” e desiderio di naturalezza, da cui germinerà la scrittura delle Operette morali.
Fu F. Nietzsche, con buon auspicio sull’interessata apologia rondista, a comprendere, dopo il Giordani, il valore di questa ricerca leopardiana. Egli che non esita a definire Leopardi “il più grande prosatore del secolo” e che nella “Gaia scienza” celebrava quella “buona prosa” che si scrive “sotto gli occhi della poesia”, in una feconda, eraclitea condizione di “guerra perpetua”.
Con le Operette morali la parabola filosofica di Leopardi tocca lo zenith, chiarendogli alla luce impietosa del “vero” tutte le ragioni, palesi e recondite, del suo abito mentale materialistico e pessimistico.
Leggi “Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani” di Giacomo Leopardi





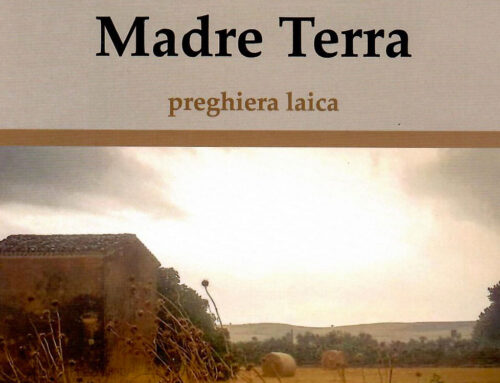


Scrivi un commento