Figura “leggendaria” della letteratura italiana del secolo scorso, autrice di numerosi scritti a partire dal secondo ventennio del Novecento (primo romanzo per la Mondadori Editore I racconti della terra, 1924; la raccolta di novelle Marcia Nuziale, 1932, uscita per la Bompiani; con la raccolta di novelle Storie di paese, 1930, considerato il suo capolavoro, si aggiudica nel 1931 il secondo posto al Premio Viareggio), collabora come giornalista sui quotidiani nazionali de IL MATTINO, IL TEMPO, IL MESSAGGERO, IL ROMA.
Lina è figlia del medico Michele Pietravalle, a lungo deputato radicale, autore di importanti scritti scientifici e originario di Salcito, allora paese di tremila anime in provincia di Campobasso, di cui la famiglia è stata anche feudataria e in cui la piccola Lina torna in estate per vivervi indimenticabili giorni, immersa tra le spighe del grano, a giocare fino al calar del sole nei campi e ad assaporare i canti popolari che i contadini amavano intonare durante la mietitura. Ricordi indelebili di una terra arcaica, mitica, il Molise, da lei – nata a Fasano (BR) l’11 aprile del 1887 – scelta come terra di elezione, che farà da sfondo – con le sue tradizioni, le sue leggende, i suoi castelli medioevali, i suoi paesaggi selvaggi – a tutte le sue opere.
Una fanciullezza trascorsa, a partire dal 1894, nel Collegio “Villa della Regina”, sulle colline di Torino, per via dei vari trasferimenti del padre, nella ricca biblioteca locale si nutre di letture dei romanzieri russi Tolstoj e Dostoevskij, in particolare, pur rimanendo sempre fedele al modello di Giovanni Verga e agli autori della corrente verista e decadentista. Quando infatti nel 1871 compare per la prima volta il romanzo verghiano “Storia di una capinera”, in forma epistolare, la giovane Lina – che si nutre di personaggi che accendano il suo animo triste e a tratti bellicoso – si immedesima “anima e corpo” nella giovane protagonista Maria, costretta dalla sua famiglia a destinare la propria felicità, appena abbozzata all’amore per il bel Nino, alle grate di un convento di clausura.
Quando finalmente può far ritorno a Napoli, dove il padre è diventato Direttore sanitario degli Ospedali Riuniti di Napoli, vi conclude gli studi presso il Suor Orsola Benincasa e vi conosce Pasquale Nonno, anch’egli originario del Molise, di un “paesetto con quattrocento anime semplici intese a pasturare, mungere capre e pecore, e seminar biada e patate; grano quasi nulla; la vigna un leggendario ornamento verso le rive del Trigno che lì ha foce oscura e barbarica…”, vale a dire Chiauci, in provincia di Isernia (villaggio oggi di meno di 300 abitanti, che affaccia sulla diga artificiale omonima).
I due si sposano nel 1907 con una cerimonia nuziale a Napoli, seguita da festeggiamenti condotti proprio a Chiauci, paese natale del marito e dei suoi genitori, orgogliosi questi ultimi che il proprio figliolo abbia sposato una giovane molisana.
Proprio l’arrivo degli sposi, trasposto in forma di novella (il genere più congeniale alla Pietravalle), dà il via alla narrazione di Marcia nuziale.
“Parlerò delle mie prime nozze – la Pietravalle sposerà in seconde nozze, nel 1925, rimasta vedova, l’architetto Giorgio Bacchelli, fratello dello scrittore Riccardo – e dell’arrivo in terra di Molise come di un fatto leggendario successo a una larva di me, che guardo curiosamente come una di quelle farfalle irrigidite nei vaghi colori, col corsaletto fulgido trafitto dall’inesorabile spillo. Vissero, non vissero? Attraversarono un giorno il sole, inebetite dall’ubriachezza della vita effimera? V’erano alberi mansueti, cieli clementi e fioretti gentili che guardavano volare i pappi di seta, i calabroni d’oro ed anche queste grandi farfalle con gli occhioni sporgenti, tatuate ed ingemmate come regine. Ma il perfido amatore era in agguato con lo spillo assassino e addio, povera farfalla! Sempre viva, uguale, vitrea pare ma non c’è più davvero. Ora anch’io mi domando: questa storia mi appartiene? È vero che ho sposato a vent’anni un uomo della mia terra, da lui per primo ricondotta ai miti sacri e ai riti adorabili e ch’egli fu con me infamemente travolto, ed io rivissi ancora ed egli scontò con la morte il suo errore? Errore di semplicità, perché era nato e cresciuto in un primitivo villaggio di pastori detto “Terra Clavicorum” nel Medio Evo, tant’era lontano dal mondo, e rompere le leggi del sangue e della natura non poteva senza perdersi e morire. Ma ricordiamoci dunque le nozze leggendarie […]”
Tali nozze avvengono a Napoli, in “una stanza grandissima della nostra tetra casa napoletana di Cisterna dell’Olio”, al cui interno “le monachelle dolci degli ospedali diretti da mio padre e un sacerdote miracoloso mi composero un altare di rose bianche, il cuscino su cui posavamo genuflessi lo sposo ed io… il velo infinito seminato di rametti freschi di fiori d’arancio… alle pareti festoni di azalee e giunchiglie pallide, e grandi magnolie superbe negli angoli, riversate dai giardini gloriosi di Posillipo.”
“Linuccia, le rose ti han dato battaglia!” nelle parole dello sposo, che la Pietravalle definisce “dannunziano, graziosamente barocco ed esagerato” e che, in treno, quasi divertito dello sgomento della sposa, le annuncia: “Vedrai al pagghiese adesso! Vedrai la tribù in festa! Le fantasie, gli onori, i furori, al Ras e alla sposa del Ras. Ti riporterò a Roma coi braccini rotti e le gambe di gesso. Quanto a me, mi vedrai dormire tre giorni e tre notti ubriaco come Nerone!”
Il viaggio in treno dei due giovani termina alla stazione di Pescolanciano, raggiunta all’alba.
“Lì finisce la ferrovia ed incomincia, tra rocce scabre, la foresta con la sua cupa grandezza ascetica.”
Così la scrittrice in una delle tante descrizioni dell’aspro paesaggio molisano, come di seguito: “La strada borbonica era bellissima. Lenta come il ritmo del tempo d’allora, strada calma e patriarcale che rispettava ogni lembo di terra ed ogni diritto di pastura. (…)
“Eran pronte ad attenderci due cavalcature con un uomo sanguigno e baffuto, Gatà, (ndr. Gaetano, probabilmente) che era a parte del nostro disegno di giungere di nascosto a tergo del paese, verso sera.”
– Ti piace, Gatà, la Novella? (Novella è come viene chiamata in questo caso la giovane sposa) chiede il marito.
- Adda piacere a voi e speriamo che faccia figli.
- E perché non li deve fare?
- Ah, padrone, che t’ho da dire? È troppo “sonella”. (sta per “snella”)
E ancora, una volta giunti alla Taverna del Boce, dove i due mangiano “uova fresche cotte nella cenere, la pizza del mulinaro col pepe, l’olio ed i semi d’anici, e fragole scolorite di delizia piene di terra”, l’oste, nel suo molisano arcaico e gutturale, parlando della sposa:
- Dice (il marito alla Novella) che sembri la lana di maggio, quella che non si torce e non si fila e non è buona a nulla
- E come debbo fare, Boce?
- “Falla lavare col vino così si arroscia, e dalle da mangiare carne di pecora e muacco!
- Ah, ah! Che è muacco?
- Il muacco è polenta con orzo, patate e pepe rosso.
- E che di più?
- Olio e aglio.
- Benedetto sia! Dammi il muacco e ti farò un figlio all’anno! Poi li manderemo a pascere.
S’arriva pertanto “nella piccola terra deserta alla Foce del Trigno”, atmosfera medioevale delle abitazioni, odor di latte e di resina, “sulle porte gufi morti inchiodati, corna cupe di vacca, e ramificate di cervo misteriose come geroglifici.”
Fiaccole e fuochi che si accendono all’improvviso in ogni piccolo angolo del bosco, gruppi di ragazzi che urlano come i lupi: “Evviva la Novella! Evviva don Pasqualino!”, un querulo suono di banda e campane dolci abituate a un tempo immoto, e pifferi, nacchere e strumenti silvani zufolano ariette e “totari” d’un suono orripilante ad attendere gli sposi per i festeggiamenti mossi dal suocero, bellissimo e truculento capo-tribù (sindaco, notaio, consigliere provinciale con medaglie al valor militare e civile di ogni genere), che ha imposto a tutta la minuscola comunità di manifestare il proprio primitivo tripudio.
La Novella sta per scoppiare in lacrime, si tura le orecchie e grida al marito: “Ma questa è Pastagonia!”. E lui: “Ma ti piace?” “Tanto! Tanto!”
Ed ecco il rito dell’investitura da parte del suocero, don Diego, impettito di medaglie:
“Su un piatto pane, olio e sale e le chiavi della porta maggiore che era quella della casa comunale. L’antico rito si compiva, come nei fasti del Trecento, fasti di grande alterigia e di commossa umiltà, nel quale il sangue dell’arrogante signore e quello del torbido plebeo eran confusi come in un crisma perfetto.
Una schiera di fanciullette, vestite di mussola bianca, con duri veli e rose di carta, si fece avanti a ghirlanda, seguita da una maestra monaca, cantando con le voci bianche ed acerbe dei campi, incrudite dal gergo, questa strana canzone: «Vieni, mia sposa, al talamo, viene dal Libano e sarai incoronata….» E ancora. “Andava la bella vergine e la portava l’armonia degli angeli, poi ristette a mezzo del tempio e chinò il capo, quale giglio satollo della rugiada.”
E dire – aggiunge Lina Pietravalle – “che queste parole eran dette da bocche ignoranti di ragazzette, e verginelle selvagge fuggenti alla peste umane”, vestali ignare, dunque, di un rito ancestrale.
«Lina ascolta! È il cantico dei cantici!» egli mi disse. Il suo volto era vitreo d’ambascia ed il suo sorriso convulso. La folla intanto irruppe: donne, uomini, vecchi; sulle finestre rozze coperte colorate e scarselle accese, sui tetti torcie bluastre di resina e le strade pavesate di tele tessute in casa, rigide e grezze. (…) Ogni arca si era svuotata delle sue più gelose dovizie e su quel fondo d’innocenza casalinga spiccavano amuleti e voti pagani, stelle, lune, vampiri.
«Compari e comari» gridò mio suocero attaccando un energico moccolo «non fate i cafoni zulù! Largo alla sposa, per Sant’Onofrio rimbambito!»
L’atmosfera, infuocata di clamori più da bestie che da uomini, sembra ora farsi Baccanale.
“Piovevan baci a mitraglia sul mio vestito e sulle mani: baci duri, informi, disperati e pianti macabri come se fossi nel cataletto.”
E piovono, come fulmini, le formule augurali:
- Figlia di sangue gentile! Palma! Figlia di mamma beata!
- Nessuno vi possa spartire!
- San Prospero vi allarghi la casa come il maggese!
- Figlia di mamma miracolosa! Soperchio, soperchio! (specchio, specchio!)
- Santa Lucia ciechi il malocchio!
- Servi a cento e mai il medico e lo speziale!
- Sant’Agnese diletta! Santa Marzia preferita!
E quando la giovane sposa, frastornata e spinta tra la folla, perde le forcine dei capelli e le trecce le si sciolgono sulle spalle:
“Essa porta una quartana di capelli. Capelli e figli assai, capelli e grano assai!”
E il grano, così scarso nelle madie:
“Infatti il grano ci copriva e non potrò mai dimenticare tra quelle luci labili, sotto quello spesso cielo di viola, arcato e dipinto come un portico, la pioggia lene e torpida del grano da tutte le finestre. Pareva polvere sfarinata d’un mestissimo oro, pieno di piombo e di ferro, e sulle mani e sul viso sentiva ancora di sole e di terra. Era tutto grano mondo, pane strappato alle loro bocche penitenti dalla poesia del mito e dalla virtù della tradizione. Una muta di servi gettava denaro e confetti e a tutti i capi di casa che attendevan sulle porte era dato il dono della sposa: un fazzoletto fiorito alle femmine, ed un taglio di camicia agli anziani. Ai fanciulli, rauchi di tripudio, ciambellette, frappe e fichi secchi…”
E ancora laudi, una volta giunti nella piazzetta ove il venerando castello scopriva il suo profilo baldanzoso. Qui ancora donne, “maniche a palloncino e fianchi d’anfore etrusche”:
- Oh la figlia! Oh il figlio! Le grandezze! Le bonezze! Benediteli, madre carnale, madre onorata! Oh quanti triboli, quante catene, ma godi, godi, donna Elvira!
Donna Elvira, la suocera, a questo punto le va incontro “come santa Elisabetta quando portava il saluto divino” e, con viso irrorato di pianto, la accoglie:
- Oh, figlia senza peccato, vieni!
- Mammà, sei contenta? Per la smania della figlia, mi hai fatto sposare “ninno di fascie!”
- E giù tutti a ridere per questa sua “botta alla paesana.”
E poi:
- Ti piace la Novella?
- Oh, figlio, ti raccomando, non fare come tuo padre, amala, prezzala. E compassione abbi…
- Ho detto se ti piace e non cantare!
- Ma sì, figlio. E compassione abbi, ch’essa mi par dipinta da San Luca!
- Nel corso della narrazione – e contro ogni prototipo di suocera di un tempo, che metteva duramente alla prova ogni nuora – donna Levira, come era chiamata, “troverà virtù strane che non ho mai posseduto e spiegava i miei difetti come ornamenti necessari”:
– Capisce epperciò è superba. La signora va con le penne in testa.
- È come la salvia gentile: poco pare ma dove la metti acconcia
- È la palma della casa. La vedeste com’è chiarita? La vedeste, quanti capelli? Diceva ai tanti uomini giganteschi, donne rigide ed olivastre e ragazzetti rossi come pomi, che le chiedevano sempre come la Novella si comportasse.
- Che te ne fai, Patìna, se essa è schiarita e sfiatata come una scòrcia di cipolla? La femmina deve alzare il bidente ed essere pasciuta. La Novella è senza petto e falla mangiare.
- L’occhio pregiato è il nero ed il celeste. Mammà, io non ce l’ho né neri né celesti ed ella – Voi ci avete una bella accigliatura e quando una femmina è bene cigliata, ci ha tre quarti più di un quarto.
Donna Elvira, che mai era stata amata dal marito-padrone, guardinga e trepida “che la felicità e la pace non potessero durare”, ecco che si fa vestale della giovane nuora, la rende accetta nella sua straordinarietà (Lina – come ha spiegato don Diego ai municipali – “non è una femmina con i polsi grossi, ma pregiata di figura e col cervello fino, ed inoltre parla meglio di monsignore”), perché “la vita buona, credetemi, è un’affacciata di finestra.”





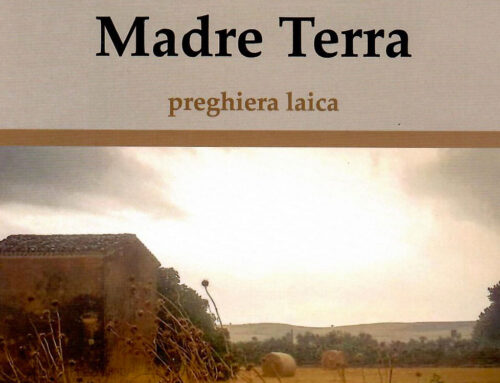


Scrivi un commento