Roberto Benigni ha la dote di rendere popolare l’oggetto delle sue esibizioni, per altro assai contrastate. In primis da quei detrattori che animati da antipatia personale e/o politica lo dipingono sempre e comunque nei panni del “pagliaccio comunista” dai compensi milionari (ovviamente immeritati). In uno con i sodali della stessa cerchia: Fabio Fazio e Roberto Saviano, giusto per fare un paio di nomi.
A un livello più alto, Benigni è inviso a chi di volta in volta gli preferisce i veri o presunti specialisti, magari scoperti proprio all’indomani del successo da lui ottenuto. Qualche anno fa, fu bocciato come lettore popolarissimo di Dante, perché non ritenuto all’altezza di un Vittorio Sermonti, per esempio. Non possedendo titoli da giurista, fu poi bocciato anche come divulgatore della Costituzione. Stessa storia, qualche settimana fa a Sanremo, con il Cantico dei Cantici, materia – sempre secondo i critici benaltristi – per esegeti biblici o fini dicitori di più fine dicitura.
A nulla è valso replicare, in questo caso, con i commenti ammirati di un esegeta con le carte in regola, come il cardinale Ravasi, o con la recensione favorevole di «Avvenire», il quotidiano della Cei. E meno che meno con i dati Auditel, che hanno indicato nel monologo di Benigni l’impennata record della serata sanremese.
Di tenore diverso, le critiche di quanti hanno accusato Benigni, anziché Salomone stesso, di pornografia in versi. Magari sarebbero state meno aspre e ingiuste tenendo presenti i brani della cantica recitati da Noodles/De Niro in C’era una volta in America e quelli che Umberto Eco, ne Il nome della rosa, aveva adattati all’impeto del giovane novizio Adso de Melk per la ragazza posseduta nella buia e fumosa cucina badiale, poi plasticamente illustrato da Jean Jacques Annaud nel film tratto dal romanzo.
Non potevano mancare, infine, le critiche mosse a Benigni per aver osato accostare l’amore eterosessuale cantato nel Cantico ad altri amori, primo di tutti l’amore gay. L’amore carnale della contadinella sulamita per il suo bel pastore può ben essere stato trasfigurato migliaia di anni fa nell’amore di Dio per l’umanità, e quindi nelle nozze mistiche di Cristo con la sua Chiesa. Ma guai a volerlo riferire all’amore di un uomo o una donna per un amante dello stesso sesso.
Bene (o male, secondo i punti di vista), certo è che Roberto Benigni ha dato o tornato a dare popolarità al Cantico dei cantici, nei cui confronti la letteratura molisana ha qualche merito. Lo rivendicava un articolo apparso il 25 marzo 1900 sulla rivista letteraria «Idea Nova» che si pubblicava a Roccamandolfi. Sì, a Roccamandolfi, dove per giunta, in quegli anni, si dava alle stampe addirittura una rivista letteraria concorrente, «Italia Moderna». E l’una e l’altra vantavano collaborazioni di prestigio da tutta la penisola. L’autore, all’epoca ventenne, sarebbe diventato un musicologo di fama mondiale, Raffaello De Rensis (Casacalenda 1879 ‑ Roma 1970): uno dei pochi molisani accolti nel monumentale Dizionario Biografico degli Italiani della Treccani.
Dopo aver lamentato il disinteresse dei molisani per la storia patria e i corregionali degni di essere conosciuti e ricordati, lamentela di perdurante attualità verrebbe di dire, Raffaello De Rensis indica in monsignor Luca Nicola De Luca da Ripalimosani l’autore dei tre “volumi di dissertazioni sul Cantico dei Cantici, che per desiderio di Papa Pio VI, egli tradusse, prima parafrasando, poi in versi”. Vescovo di Muro Lucano, poi di Trivento, “ingegno versatile e profondo, tale da goder fama di letterato, filosofo, teologo come di giurista e di felice interprete di tutti i libri sapienziali della Bibbia, primo maestro di Gaetano Filangieri”, il vescovo De Luca fu autore di una traduzione coerente e logica ma non poeticamente riuscita perché ancorata ai modelli della Arcadia settecentesca. Sul versante critico e filosofico, invece, confutava con vivacità polemica le opinioni di Voltaire e altri, “analizzando le allegorie, le verità nascoste, le finezze poetiche del Cantico da nessuno studiato così dettagliatamente e in profondità”.
Preferibile alla versione del vescovo De Luca – sempre secondo De Rensis – è la traduzione pubblicata un secolo dopo, nel 1868, da Vincenzo De Lisio, galantuomo di Castelbottaccio di stampo anticlericale. Per De Lisio, che si rifà alla vulgata, “la cantica non è che una lirica in tutta la bellezza della magnificenza orientale – una suprema manifestazione dell’artista che canta l’amore e volerne stiracchiare le parole, contorcerne i concetti e attenagliare le allusioni… mi sembra proprio un’inquisizione”. Ciò nonostante, De Lisio “sfortunatamente, cade, a causa di moltissime e quasi testarde divergenze con gli altri traduttori, per mancanza di tecnica poetica italiana e per frequenti infedeltà, derivate dall’uso della terza rima, nei medesimi errori che vorrebbe e crede di sfuggire”.
Sappiamo da altra fonte (Achille De Rubertis, Niccolò Tommaseo nelle sue relazioni con alcuni letterati molisani, in «Rassegna storica del Risorgimento», 1938) che nel novembre 1869, Vincenzo De Lisio aveva spedito una copia della sua traduzione al Tommaseo, il quale non si sottrasse al riscontro, che con qualche apprezzamento si risolveva in una garbata ma inappellabile stroncatura di una traduzione caratterizzata anche dal disprezzo ostentato dall’autore per le “pagine sacre”.
Tornando a De Rensis, a suo avviso, la migliore traduzione del Cantico dei cantici è quella di Leonardo Girardi, letterato di Petrella Tifernina di formazione neoguelfa: opera di “squisitezza e genialità sentita”, “fedelissima” e nel contempo “conciliabile con le più disparate interpretazioni ed ha la forbitezza della lingua e la fluidità del verso sciolto”. Risalente ai primissimi Anni Cinquanta dell’Ottocento, pubblicata nel 1870, fu “reputata a molte superiore, a parecchie uguale, a nessuna inferiore”.
E allora, se è così, perché non rispolverarla, perché non provare a ridarle vita, perché non rilanciarla, se non altro come un’eco molisana alla performance di Benigni, affidandola alla cura e alla voce di uno Stefano Sabelli o un Diego Florio?
In conclusione, per non fermarci alla ricognizione di Raffaello De Rensis, va sottolineato che l’interesse molisano per il Cantico risale a secoli assai più remoti. Il celebre Ambrogio Autperto, che da cancelliere di Carlo Magno si fece monaco benedettino a San Vincenzo al Volturno nel 774, scrisse uno sterminato commento dell’Apocalisse in dieci libri, giunto fino a noi. Ma non solo. Nella sua breve vita claustrale che lasciò quattro anni dopo, da abate, Autperto scrisse altre opere esegetiche, andate purtroppo perdute, sul Levitico, i Salmi, e per l’appunto il Cantico dei Cantici.



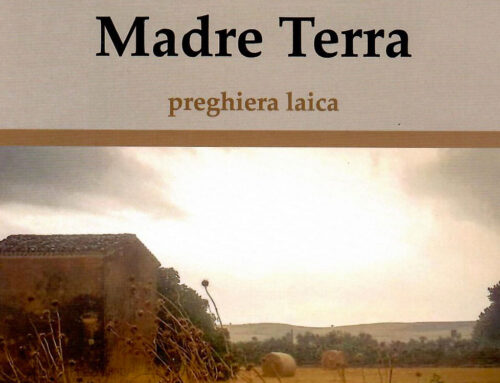




Scrivi un commento