Sul Pungolo verde, il periodico campobassano tanto bistrattato da Umberto Eco, pubblicava i suoi versi d’esordio il poeta Nicola Iacobacci (Toro 1935 – Campobasso 2018). Si era alla fine degli anni Cinquanta. Iacobacci esordiva mentre calava il sipario sul decennio d’oro della letteratura molisana, finalmente approdata alla ribalta nazionale, narrando del Molise e dei molisani.
Ad aprire il decennio e la serie di capolavori, grandi e piccoli, Le terre del Sacramento, il romanzo postumo di Francesco Jovine da Guardialfiera, vincitore del premio Viareggio 1950.
Gli avevano fatto eco dall’altro versante della vallata del Biferno, i bestseller del casacalendese Giose Rimanelli, Tiro al piccione (1953), Peccato originale (1954), Biglietto di terza (1958) e Una posizione sociale (1959), suggellati e in un certo modo archiviati con Il mestiere del furbo (1959), una raccolta di saggi al vetriolo sulla narrativa italiana del tempo, pubblicati con lo pseudonimo, presto smascherato, di A.G. Solari.
È del 1950 anche il volume di esordio di Luigi Incoronato da Ururi: Scala a San Potito, ambientato nella Napoli distrutta e misera del dopoguerra. Molisani, invece, la raccolta di racconti, che aveva per titolo e per teatro il paese di origine dell’autore, ribattezzato Morunni (1952), e il romanzo Il governatore (1960), che narrava dell’arrivo delle truppe inglesi e americane in due paesi indicati anch’essi con nomi di fantasia: Lenno e Bontora (Ururi e Larino?).
Un altro romanzo d’esordio, La chiesa di Canneto di Felice Del Vecchio, si aggiudicò nel 1957 il Premio Viareggio “Opera Prima”. Nato a Castiglione Messer Marino, il ventottenne autore era molisano di elezione. Cresciuto a Roccavivara, liceale a Campobasso, si era potuto iscrivere alla Facoltà di Filosofia a Pisa, alunno della Normale, grazie a una borsa di studio della provincia di Campobasso. Laureato brillantemente nel 1951, era ritornato in Molise e per qualche anno vi aveva svolto attività politica nel Partito Comunista, prima di trasferirsi definitivamente a Milano.
Nicola Iacobacci aveva letto e amato quei libri, tra i quali vanno inserite anche le Poesie molisane (1955), produzione ultima di Eugenio Cirese, che finalmente libero dalla facile cantabilità pseudopopolaresca, aveva trovato un convinto ammiratore in Pier Paolo Pasolini.
In quei libri Iacobacci riconosceva se stesso, la sua gente, il mondo della sua infanzia contadina. Come Toro, anche Guardialfiera e Casacalenda, Fossalto e Castropignano, e Ururi, Larino e Roccavivara: isole diverse di una sola storia senza storia.
Iacobacci avrebbe trasfigurato quel mondo con poesie, monologhi, romanzi, dai quali non poteva non spirare un’aura di inevitabile epicedio. Era stata la cultura del villaggio contadino a temprare la sua gente, forse rozza ma gentile, piegata al volere di Dio eppure capace di sogni grandiosi, come quelli di pane e concordia dei coloni di Morutri, o dei devoti di San Giuseppe a Roccavivara e in decine di altri centri molisani: sogni addormentati se non annichiliti, che avevano alimentato ideali di giustizia e fraternità.
Scomparsi, Jovine e Cirese, il poeta non emulò nelle loro fughe i più celebrati Incoronato, Rimanelli e Del Vecchio. Di qualche anno più giovane, a stretto giro stilò il suo testamento letterario:
Non lascerò il Molise
trafitto da occhi dolenti di madri:
questo sole che abbruna gli ulivi
m’inchioda alla terra degli avi
che pascolavano greggi ai tratturi
intrecciando canestri
per gli agnelli appena nati;
il mio Molise
con le donne che cercano fragole ai boschi
e portano scarpe di gomma
nei giorni di pioggia.
A quel testamento, che è del 1969, rimase fedele. E dal suo esilio d’oltreoceano, Rimanelli finì per accorgersi del poeta schivo, innamorato della poesia e della sua terra. Dedicò un saggio assai cordiale a Di/spero (parole al muro), liriche pubblicate nel 1987, presentando ai lettori di lingua inglese una bella traduzione della bellissima A mia madre, meritatamente celebre:
In questa stanza bianca
la lingua è legata nella bocca
come il battaglio della campana
nei giorni di passione;
ancora un giro intorno all’asse:
l’eternità gorgoglia nell’acqua
accanto alla bombola d’ossigeno.
Dal vetro brunito della finestra
lampeggia la prima lucciola;
tante lucciole tra i fili della memoria
impigliati a tarda sera
nei cespugli fioriti della costa.
È il segno dell’età,
felice perché passata:
l’attimo non rivela la gioia
o il dolore che lo sostiene.
Tempo d’addio:
la sedia di paglia è già pietra
per l’allodola stanca di volare.
Di lì a poco, anche Felice Del Vecchio che, dopo un trentennio di lontananza e di silenzio, aveva ripreso a frequentare la sua terra di origine, conobbe Iacobacci grazie a un’antologia delle sue opere tradotte in francese da Patrice Dyerval Angelini, la traduttrice di Montale per Gallimard: La volontà d’essere/Volonté d’être (1990).
All’amico che gliela aveva proposta in lettura, Del Vecchio inviò un’analisi critica stimolante e assai lusinghiera. Iacobacci ebbe modo di leggerla e di apprezzarla. Tra i due ci fu l’avvio di uno scambio epistolare che prometteva di rivelarsi interessante ed ebbe, invece, un esito a sorpresa, anche se divertente.
Era successo che alla lettera di ringraziamento di Iacobacci, Del Vecchio aveva risposto con tempestività, salvo lamentarsi a telefono, di lì a qualche giorno, con l’amico comune che li aveva messi in contatto, per la scrittura indecifrabile e indecifrata del poeta, a causa della quale si era dovuto accontentare di inviargli un riscontro generico, assai poco significativo.
Dal canto suo, a distanza di pochi minuti dalla telefonata, un ignaro e trafelato Nicola Iacobacci bussava alla porta dello stesso amico, agitando un foglio di carta, per pregarlo di provare a decrittare la risposta di Felice Del Vecchio, che lui non era riuscito a interpretare in nessun modo.
Insomma, una corrispondenza stroncata sul nascere per incompatibilità di carattere. Caratteri corsivi, si capisce, illeggibili in entrambe le grafie.





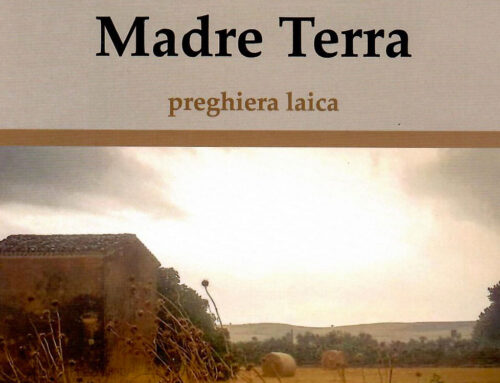


Scrivi un commento